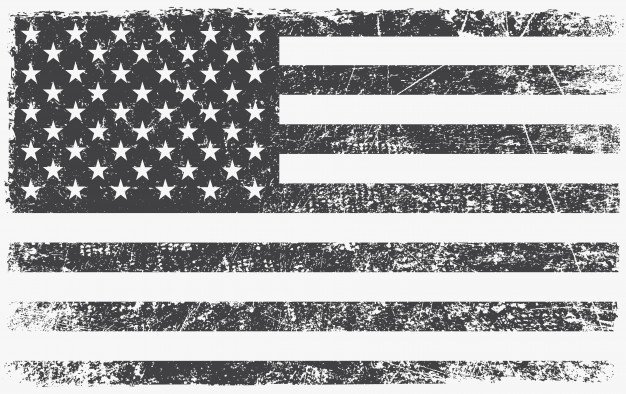Un approfondimento sugli alawiti, alla luce degli ultimi eventi in Siria con la caduta del regime di Assad, a cura di Tommaso Balsimelli per Il Tazebao.
Il Tazebao – La transizione “democratica” che doveva avvenire in Siria con i militanti jihadisti salafiti si è, senza molte sorprese, già interrotta. La popolazione siriana alawita e cristiana della costa ha dovuto assistere con orrore all’entrata nelle loro città di camionette con la bandiera dell’ISIS e poi a quella che si può solo definire come pulizia etnica, in parte per odio etnico-religioso da parte dei militanti dell’HTS e parte come risposta alla nuova insorgenza politica in Latakia e Tartus che riprende alcuni ideali del precedente regime. Una storia, quella degli alawiti, quasi sconosciuta, che proveremo a ricostruire.
La nascita
Il fondatore del movimento fu Ibn Nusayr Al Numayri, che visse nel periodo degli ultimi imam legittimi per gli sciiti, ovverosia Al-Hadi (Rayy, 764 – Baghdad, 786) e Al-Askari (Medina, 846 – Samarra, 874), cioè nel nono secolo Dopo Cristo. Egli fu compartecipe delle vicende di Al-Askari. Dopo l’uccisione di Al-Askari da parte del califfo abbaside Al Mu’tamid, i sostenitori della linea di sangue di Alì continuano ancora oggi a sostenere che il figlio di Al-Askari, il dodicesimo e ultimo Imam, sia ancora oggi protetto e tenuto in vita da Dio e che tornerà per la Fine dei Tempi, il cosiddetto Mahdi, insieme a Isa, cioè il Gesù islamico.
Ibn Nusayr diede inizio a un sistema mistico in un’epoca, quella del califfato abbaside, di traduzioni di opere antiche dal greco, dal siriaco e dal persiano. La grande traversata della produzione intellettuale antica nel Medioevo sarebbe stata, infatti, molto più povera senza il contributo islamico. L’essenza della sua dottrina era trovare il significato comune tra le tre religioni abramitiche, partendo dal fatto che religione non era mai menzionata al plurale nel Corano, focalizzandosi più sulla fede.
Tratti distintivi della dottrina
La dottrina alawita è molto difficile da comprendere nella sua totalità, essendo un sistema mistico in cui gli aderenti vengono a sapere sempre più nozioni inerenti al loro credo via via che accedono ai gradini più alti della loro gerarchia. Sostanzialmente gli alawiti attribuiscono una natura divina a tutti e dodici gli Imam considerati validi dagli sciiti, da Alì all’attuale Madhi, che ha contorni messianici.
Gli alawiti hanno un concetto di reincarnazione che assomiglia all’induismo, al buddismo e a certe concezioni dell’antica Grecia, cioè vivere più vite su questo mondo finché non ci si è completamente liberati dalle scorie terrene. Questo si ricollega alla loro credenza che l’umanità abbia perso la sua connessione più diretta con il divino “cadendo dalle stelle” e non con una tentazione simile al resto della teologia abramitica. Gli alawiti posseggono un concetto molto particolare di “Trinità” dove Dio opera nel Mondo, la cui Storia è suddivisa in sette ere, attraverso tre Persone che rappresentano un Significato di tale era (Ma’na), un Nome (Ism) e una Porta (Bab), rispettivamente il Logos fattosi carne, il suo Profeta e colui che dà inizio alla nuova era attraverso la Porta costruita da tale Profeta.
Molti protagonisti della Bibbia, tra cui Gesù e Pietro apostolo, sono ricontestualizzati in questa teologia. La Shahada – la testimonianza di fede – alawita sostituisce Allah con Alì, riconducendosi al fatto che lo vedono come reincarnazione divina dell’epoca corrente e come sorta di “guardiano” divino del Profeta dell’epoca corrente. Va notato che la Porta associata a Maometto, oltre che l’autoproclamazione di Nusayr di essere Bab dei Dodici, era un filosofo e scrittore zoroastriano, Salaman Al Farisi, suo discepolo.
La preghiera alawita generalmente non è rivolta verso La Mecca ed è compiuta a livello personale o familiare che comunitario. Essa si suddivide in invocazioni delle figure principali del partito sciita e della loro dottrina, cioè Alì, Maometto, Salaman e la famiglia del Profeta. La Jihad è intesa in maniera puramente difensiva e protettrice delle conoscenze esoteriche della comunità alawita. Le tasse religiose tipicamente prescritte dall’Islam, così come la Sharia, sono interpretate in maniera larga e gli alawiti sembrano dare importanza alla presenza di pane e vino santificati, similmente al Cristianesimo. L’idea dei Dodici come manifestazioni divine fattesi carne sembra similare alle dottrine cristiane docetista e quella monofisita, che erano ancora molto diffuse in Egitto e nel Levante.
Il difficile cammino degli alawiti
Nusayr si scontrò con quella che è l’attuale corrente maggioritaria degli sciiti, che non riconosce alcuna natura divina ai Dodici e che ritiene ci sia stato un periodo di “minore occultamento” in cui quattro prescelti abbiano comunicato con il Mahdi per circa settant’anni (871-940), prima del Grande Occultamento (940-presente). Nusayr invece diffuse l’idea che fosse lui l’unico interlocutore del Mahdi. Con la morte di Nusayr (868) il suo studente Al-Janbalani portò avanti i suoi insegnamenti e dottrine e inviò i suoi due migliori allievi, Alì Al-Jali e Alì Al-Jesri a promuovere il nuovo credo partendo dall’Iraq. La comunità si ingrandì sulla costa siriana e con immigrati iraqeni in un secolo, nell’epoca dell’emirato di Aleppo retto dagli Hamadanidi sciiti, quindi protetti da persecuzioni.
L’emirato di Aleppo divenne un vassallo bizantino nel 970 e gli sciiti furono la seconda corrente di pensiero islamico più diffusa nel Nord Africa, nel Levante e nella stessa penisola araba fino al dodicesimo secolo, rivaleggiando con i sunniti, per poi rifiorire nell’altopiano iranico dal tredicesimo secolo in poi. La maggior parte dei testi canonici alawiti erano già stati composti nel quando il movimento fu rivitalizzato da Ibn Yūsuf Al Makzūn (1164-1240) che giunse ad Al Ǧabal con il suo esercito, salvò gli alawiti dai predoni curdi ed espulse gli ismailiti da alcuni dei loro castelli. Gli alawiti sopravvissero agli orrori delle Crociate, dell’invasione mongola, della peste nera e di Timur.
Tra il 1305 e il 1315 il dottore islamico Ibn Tamiyya compilò una fatwa contro gli alawiti, istigando i sunniti a ucciderli a vista e questo portò la comunità a essere più riservata nei confronti dell’esposizione della loro dottrina, oltre che a ribellarsi contro i tentativi dei Mamelucchi d’Egitto di assimilazione e genocidio tra il 1316 e il 1317.
Dall’Impero ottomano al mandato francese
Nel 1516 l’Impero ottomano, sunnita, aveva conquistato la Siria e gli alawiti si ritrovarono a subire le stesse discriminazioni degli altri gruppi religiosi minoritari. Il 24 aprile 1517 migliaia di persone di questa fede furono massacrate nella Grande Moschea di Aleppo. I sopravvissuti dovettero ricollocarsi nel nord del Libano, nell’ovest della Siria e ad Antiochia. Qui si trova il Santuario di Khdir, ancora oggi importante per gli alawiti.
Durante l’occupazione egiziana della Siria da parte del Pasha di Egitto Muhammad Alì (1831-1833 e 1839-1841), gli ottomani considerarono gli alawiti di fatto degli alleati semi-indipendenti contro gli egiziani. Anche se pochi di essi raggiunsero alti gradi nell’amministrazione ottomana, solo negli anni ’90 del XIX secolo i turchi iniziarono a incorporarli nella vita locale. Dalla metà del XIX secolo le potenze cristiane provarono, senza successo, a convertirli. Storicamente chiamati sia alawiti che Nusayris, nel XIX secolo membri di spicco della comunità preferirono farsi chiamare alawiti e nel 1920 furono eletti per essere chiamati solo alawiti (Nusayris era un peggiorativo).
Durante la Prima guerra mondiale l’Impero ottomano crollò sotto la pressione militare di Gran Bretagna, Francia e i loro alleati arabi. La costa siriana e il resto della regione divennero un mandato coloniale francese. I francesi nel 1920 crearono un’entità semiautonoma per gli alawiti, anche con una bandiera. Antiochia faceva parte del mandato ma poi fu ceduta ai turchi nel 1939, una concessione mai riconosciuta dalla Siria. La costa e l’area abitata dai drusi furono unite all’entroterra nel 1942.
L’indipendenza, il partito Ba’th e gli Assad
Gli alawiti furono riconosciuti come musulmani solo nel 1932, grazie al mufti di Gerusalemme Ajj Hamin Al Husseini, che istituì in quell’anno una fatwa contro il colonialismo francese, includendoli nella umma islamica. La comunità tornò a essere rilevante con l’indipendenza del paese nel 1946, aderendo al pan-arabismo laico, egemonizzando con la violenza nel 1963 il partito Ba’th nato nel 1940 e con la presa del potere nel paese da parte di Hafez Al Assad e del suo partito nel 1971.
Hafez Al Assad era rivale di Salah Jadid (deposto nel 1971) per via della sua affiliazione comunista e della sua opposizione alla religione; inoltre, Jadid era nemico della leadership baathista in Iraq, mentre Hafez era intenzionato a colloqui di unità. Fu in questo periodo che Hafez Al Assad entrò in contatto per la prima volta con lo sceicco Al Bouti, per contrastare l’ateismo marxista-leninista. I suoi sermoni e dibattiti raggiunsero il pubblico tramite la televisione.
Il rinomato studioso islamico Sayyid Hassan al-Shirazi affermò il 17 dicembre del 1972 (1392 secondo il calendario islamico) che:
“Gli alawiti sono sciiti che appartengono al Comandante dei fedeli Ali Ibn Abi Talib (pace su di lui) per tutela, e alcuni di loro appartengono a lui per tutela e lignaggio, come tutti gli sciiti la cui affiliazione dottrinale risale all’Imam Ali (pace su di lui), e alcuni di loro hanno anche una discendenza che appartiene a lui. (Alawiti) e (Sciiti) sono due parole sinonime, come le parole (Imamiyyah) e (Ja’fariyyah). Ogni sciita è un alawita nella fede, e ogni alawita è uno sciita nella dottrina”.
A causa della natura esoterica e gerarchica dell’accesso alla conoscenza nella loro comunità religiosa, i non iniziati non ebbero mai informazioni approfondite riguardo le credenze e le pratiche alawite. Al Assad credeva che la comunità sarebbe stata beneficiata dall’integrazione dell’educazione sunnita. Mentre Hafez al Assad negli anni Settanta cercava di far riconoscere la comunità Alawita dagli sciiti, le borse di studio sunnite sostenute da Stato e ulama ebbero più impatto. I masajid sunniti furono costruiti dallo Stato in tutti i villaggi e le località alawiti, come la Moschea di Qardaha, situata nella città natale della famiglia Assad, e dedicata ad Abu Bakr As-Siddeeq, il primo califfo sunnita.
Gli alawiti furono inviati nei centri urbani per assimilarli nel resto della società siriana, proprio come Hafez scelse di lasciare Qardaha. Anche gli alawiti furono incoraggiati e inviati a compiere il pellegrinaggio per La Mecca. In un accordo tra Hafez Al Assad e Sheikh Al Bouti, 500 alawiti furono inviati per imparare la fiqh islamica sunnita all’Università di Damasco. Oggi gli alawiti proclamano la Shahada comune agli altri musulmani, credono in un unico Dio, pregano verso La Mecca e vi fanno il pellegrinaggio, hanno abbandonato il concetto di reincarnazione e non si sentono più stranieri nella umma islamica. Hafez al Assad espresse nel suo testamento che l’Imam al-Bouti conducesse il suo funerale e che la sua sepoltura fosse guidata secondo i riti islamici canonici.
La conflittualità riesplode
Già dopo un decennio, nel 1982, ad Hama scoppiò un’insurrezione guidata dai Fratelli Musulmani, di orientamento sunnita discriminatorio (nati grazie al Regno Unito), a cui si rispose con una reazione che lasciò sul posto 30.000 morti. La Siria dette il suo assenso alle operazioni militari americane contro Saddam Hussein, anche se in teoria afferivano allo stesso partito politico, per poter avere mano libera nell’occupazione del Libano.
La guerra civile in Siria – ancora in corso – è scoppiata principalmente per tensioni etnico-religiose, a cui si sono sommate richieste più liberali. Così come il governo di Damasco compì brutali operazioni militari contro le città a maggioranza sunnita, così i sunniti compirono massacri contro gli alawiti nel 2013 in Latakia e nel 2016 ad Homs.
Hafez al Assad e Bashar al Assad hanno sempre fatto poco accenno agli interessi, alle pratiche, alle credenze alawite o alla comunità, in maniera negativa o positiva. A questo punto, ha poco più che un significato culturale/tribale/familiare. Dopo il regime change degli Stati Uniti in Iraq, analisti e ricercatori ai tempi definivano la Siria una “potenza sunnita” e l’Iraq una “potenza sciita”. È improbabile che si riferissero alla fede della famiglia Assad, ma più alla demografia di entrambi i paesi e alla loro politica. Il regime siriano dopo il 2003 fu partecipe dell’insurrezione iraqena contro l’occupazione americana e la Siria e non aveva relazioni normali né con gli USA né con l’Iran.
Gli alawiti, mentre sto ancora scrivendo, si contano all’incirca sui due milioni e centomila presso la costa siriaca, libanese e nella Turchia meridionale, mentre alcune piccole sacche (forse) sono ancora ad Homs e Hama, nell’entroterra. Anche se l’influsso iraqeno è stato consistente, gli alawiti per lo più sono nativi del Levante, discendenti di cananei e aramei. Prima del 2011 erano la terza comunità per estensione in Siria. La grande emigrazione degli islamici sunniti verso Turchia ed Europa, così come dei cristiani, li ha resi la seconda comunità più grande nel paese. L’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo stima che tra il 60-70% dei giovani uomini alawiti sia stato ucciso o ferito nella guerra civile.
Gli alawiti hanno regalato diversi poeti, musicisti, scrittori e attori al Medio Oriente, oltre che essere conosciuti per la geopolitica. Ci auguriamo che le violenze terminino al più presto e arrivi veramente la “democrazia e libertà” che sono state così tanto abusate come parole dai nostri giornali occidentali.
Bibliografia
- Madeleine Pelner Cosman, Linda Gale Jones, The Nusayriyya Alawis. Handbook to Life in the Medieval World, New York, Infobase Publishing, 2009, p. 40.
- Gisela Prochazka-Eisl, Stephan Prochazka, The Plain of Saints and Prophets: The Nusayri-Alawi Community of Cilicia, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2010, p. 81.
- Yaron Friedman, The Nuṣayrī-ʿAlawīs: An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria, in Islamic History and Civilization. 77, Leiden, Boston: Brill, 2010, p. XII.
- Ivi, p. 68.
- Ayse Tekdal Fildis, Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria, in Middle East Policy, XIX, No. 2, estate 2012, Hoboken, Wiley-Blackwell, pp. 148-156.
- Aziz Nakkash, The Alawite Dilemma in Homs. Survival, Solidarity and the Making of a Community, Bonn, Friedrich Ebert Stiftung, marzo 2013, pp. 1-20.
- David S. Sorenson, An Introduction to the Modern Middle East: History, Religion, Political Economy, Politics, dicembre 2013, Boulder, Westview Press. p. 64
- Abdel Bari Atwan, Islamic State: The Digital Caliphate, Berkeley, University of California Press, 2015, p. 58.
- Raihan Ismail, Saudi Clerics and Shī’a Islam, New York, Oxford University Press, 2016, p. 67.
- Üllar Peterson, The Position of the Alawites in Islam, in Cultural crossroads in the Middle East. The historical, cultural and political legacy of intercultural dialogue and conflict from the Ancient Near East to the Present Day, editori Vladimir Sazonov, Holger Mölder & Peeter Espak, in Studia Orientalia Tartuensia, Series Nova, Vol. VIII, Tartu, Centro di Studi Orientali, Università di Tartu, 2019, pp. 163-198.
Sitografia
- Sceicco Saleh Al-Karbasi, Gli alawiti sono sciiti?, su Islam4u.com, 2009.
- Frontline, How Britain cultivated Egypts Muslim Brotherhood in the 1940s and 1950s, 28 dicembre 2012.
- Abdullah Fadel, Sarah Moussa, Hani Al Allaf & Hala W, Syria’s alawites, su Wanabqa – We will remain, 30 agosto 2022.
- European Union’s Agency for Asylum, 10.4. Alawites, 2023.
- Muslims against imperialism, Hafez al Assad and The Sunnification/Assimilation of Syria’s Alawis, ospitato su Facebook, 23 luglio 2024.
- Habib Khan, Rebels in Latakia, Syria, are carrying the ISIS flag, 11 dicembre 2024, Visegrad24, ospitato su X (Twitter).
- Fabrice Balanche, Alawites Under Threat in Syria?, su The Washington Institute for Near East Policy, 31 dicembre 2024.
- Redazione, Inattesa offensiva della Resistenza Popolare Siriana. Il Tazebao del Giorno, Il Tazebao, 7 marzo 2025.