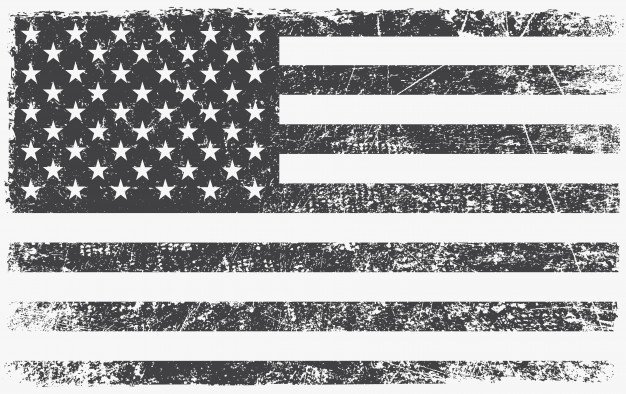Il Tazebao – L’Europa è in piena crisi da riallineamento, si muove senz’altro con l’incertezza di chi non ha deciso il proprio posto nel mondo. Il pellegrinaggio di Pedro Sánchez alla corte di Xi Jinping e l’annunciata processione dei leader europei prevista per luglio a Pechino delineano la traiettoria di un continente che cerca spazi di manovra in un sistema di forze che, in realtà, lo sovrasta.
La metamorfosi della strategia europea è evidente: ieri barriere tariffarie contro i veicoli cinesi, oggi possibilità di negoziazione. Un’apparente contraddizione che rivela non tanto una strategia quanto l’assenza di essa. Questo fluttuare tra protezione e apertura non è frutto di un calcolo lungotermista ma di temporaneo smarrimento nel caos della situazione. L’irrigidimento delle relazioni transatlantiche offre il pretesto perfetto per tentare un canale di comunicazione con l’Oriente. Ma come si potrebbe – sensatamente – indicare, l’America ha semplicemente preso atto della fine dell’ordine unipolare. I ripensamenti regionali tradiscono questo, non è un impero interessato a perseguire la grandeur al costo dell’implosione interna, ed è qui che l’Europa dovrebbe concentrarsi: gli Stati Uniti non sono interessati a farsi ingelosire per ristabilire un ordine passato, stanno imponendo una scelta di campo per il presente. I numeri, ad ogni modo, raccontano una storia che la retorica o i viaggi diplomatici non possono alterare: 4.000 miliardi di dollari di investimenti americani in Europa, l’Europa reciproca con 3.400 dei suoi negli Stati Uniti. Cifre che non lasciano spazio alle illusioni e riducono gli interessi europei in Cina a poco più di un esercizio di stile. La dipendenza economica dal gigante americano non è una condizione economica alterabile dalla volontà europea, ma strutturale, un dato che la diplomazia europea preferisce sussurrare anziché affrontare.
Il deficit commerciale euro-americano porta con sé il paradosso irlandese: 84 miliardi di surplus nel settore farmaceutico, un terzo dell’intero squilibrio, generato non da eccellenza produttiva ma da alchimie fiscali, l’Europa è in deficit rispetto agli Stati Uniti poiché benché si proclami unita nei valori, si frantuma negli interessi coltivando paradisi fiscali interni che prosperano erodendo qualsiasi pretesa di onestà dietro il progetto comunitario. L’Europa, per rendersi attore credibile potenziale, avrebbe dovuto alzare la voce anche quando la Francia ha legato un accordo di difesa disperatamente ricercato con il Regno Unito all’accesso alle acque da pesca britanniche, trasformando questioni di sicurezza in mercanteggiamenti da bazar. L’Europa, rappresentata in questa vicenda dal grugno sconcertato di Kaja Kallas, ha solo potuto osservare con malcelata impotenza la degradazione della politica in bottega. L’Europa delle grandi visioni si perde nei particolarismi più miopi ed ogni grande progetto comunitario deraglia verso i singoli interessi degli attori europei.
La guerra normativa contro la Silicon Valley completa il quadro dello smarrimento, l’Unione che ha frenato l’ascesa di propri campioni tecnologici, scambia la regolamentazione per strategia industriale. Il RGPD, monumento alla burocrazia continentale, viene ora riconsiderato non per visione ma per necessità. Mentre il futuro si costruisce già altrove, ci si attarda in battaglie di retroguardia.
L’attuale amministrazione americana, verso la quale non andrebbe nutrita fiducia alcuna, ha compreso che il mondo è in movimento. L’Europa, invece sembra incapace di coltivare leader dotati della stessa maturità. Sospesa tra Occidente e Oriente, l’Europa rischia di scoprirsi non ponte ma periferia di entrambi.