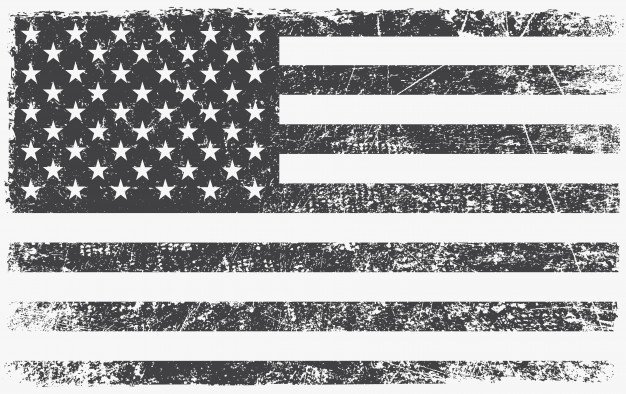I cristiano-democratici sono divisi tra la tentazione di inseguire l’AfD sul suo terreno – per svuotarla – e la necessità di preservare un’identità centrista aggregante.
Il Tazebao – Il tempo della Germania post-semaforo si misura in geometrie politiche insidiose. Friedrich Merz, il traghettatore designato per la CDU fuori dalle secche dell’era Merkel e dalla parentesi Scholz, si ritrova a navigare in acque ben più agitate del previsto. L’esercizio di succedere alla coalizione uscente si rivela un percorso minato da fratture interne e tensioni continentali. La vittoria elettorale non ha dissipato le nebbie; al contrario, ha illuminato un paesaggio politico complesso dove l’ascesa di AfD proietta un’ombra lunga sulle stesse fondamenta dell’Unione.
Il nodo gordiano non è solo la quadratura del cerchio di una coalizione – l’unica praticabile senza AfD vedrebbe CDU allearsi con SPD e Verdi, partner appena castigati dagli elettori – ma il groviglio quasi inestricabile tra le urgenze domestiche e le scosse che attraversano il continente. Difesa, energia e dazi non sono più capitoli distinti di un programma ma vasi comunicanti che alimentano un’ansia diffusa, percepibile tra analisti, cittadini e decisori. L’economia rallenta, la migrazione è percepita come fuori controllo, l’industria automobilistica scottata e in piena riconversione strategica non richiede ma esige: sono questi i dati di realtà che rendono la formazione di un esecutivo stabile non un’opzione, ma una necessità vitale. Eppure, la stabilità è merce rara. Lo spettro di AfD è il sintomo di un malessere che serpeggia all’interno della stessa Unione. La lettera infuocata della Junge Union di Colonia che ammonisce Merz sui rischi di una deriva troppo marcata a destra e sulla potenziale evaporazione della fiducia elettorale, è più di una scaramuccia generazionale. È la spia di una tensione irrisolta nel cuore del partito, combattuto tra la tentazione di inseguire l’AfD sul suo terreno e la necessità di preservare un’identità centrista capace di aggregare.
Questo stallo interno si proietta inevitabilmente sul continente Europa. Le grandi manovre sul riarmo continentale, ad esempio, sono minate dalle divisioni. L’iniziativa tedesca per un acquisto comune di armi da 150 miliardi, aperta anche a Regno Unito e Canada, trova appoggio solo di un terzo dei partner europei e la decisa opposizione francese. Berlino deve trovare la quadra per esercitare una leadership credibile senza un governo nel pieno delle sue funzioni.
Analoghe complessità avvolgono la questione energetica e commerciale. Il fantasma del NordStream 2, il gasdotto sospeso ma non smantellato, aleggia sulle discussioni relative all’Ucraina e alla futura architettura energetica europea. Una sua riattivazione spaccherebbe nuovamente il continente, tra chi vi vedrebbe un inaccettabile finanziamento a Mosca e chi (soprattutto in una certa industria tedesca) un vantaggio competitivo irrinunciabile. Nel frattempo, i dazi di Washington creano ulteriori fratture: l’industria automobilistica tedesca (già impegnata a delocalizzare parte della produzione negli USA) si sente sotto attacco.
Merz si trova così al centro di una tempesta violenta: sotto pressione per formare un governo con alleati recalcitranti o puniti, sfidato da un sovranismo quisling in crescita esponenziale, contestato da settori del suo stesso partito, e chiamato a gestire partite europee decisive con una mano legata dietro la schiena. La risposta che la Germania saprà dare a queste sfide non determinerà solo il futuro del cancellierato Merz, ma potrebbe essere un punto di svolta – o di ulteriore tramonto – per l’ordine tedesco all’interno del progetto europeo.