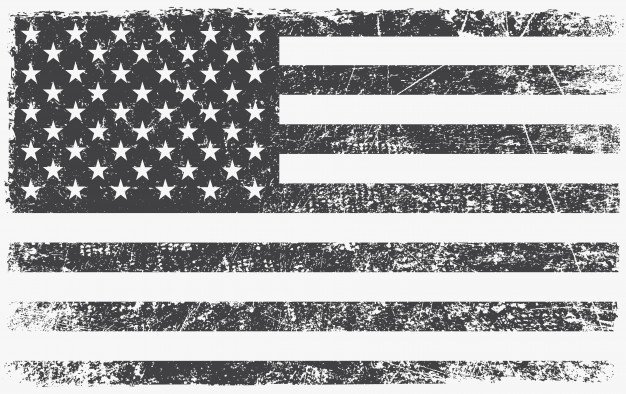Il Tazebao – L’Europa riscopre le virtù dell’autosufficienza, lo sguardo si volge verso il basso, alle profondità che per secoli hanno alimentato industrie e civiltà. L’Italia, patria di una millenaria industria marmorea e sulfurea, può oggi riesaminare il proprio patrimonio geologico in ottica strategica, trovando forse sotto i propri piedi la chiave di volta per invertire la dismissione del paese.
Mentre il mondo si ripiega su sé stesso e abbandona gradualmente le politiche di interdipendenza globale che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, la penisola italica si interroga su quanto le sue viscere possano ancora offrire. L’era dell’esternalizzazione – quella comoda pratica di delegare ad altre nazioni le attività estrattive – sembra volgere al termine, vittima di un’epoca incerta dove ogni Stato rivaluta le proprie capacità produttive. Ma non si tratta di ferro, mercurio o carbone, c’è una metamorfosi necessaria nell’intendere l’industria mineraria contemporanea. Ciò che un tempo era considerato marginale rispetto alle grandi economie estrattive mondiali diventa oggi oggetto di studio meticoloso.
Le terre rare – minerali dai nomi esotici, lantanoidi, neodimio, praseodimio, disprosio – rappresentano la pietra filosofale dell’industria tecnologica contemporanea.
Senza questi elementi, nessuna transizione verde, nessuna rivoluzione digitale, nessun futuro elettrificato. Le ricerche più recenti suggeriscono che il territorio italiano nasconda quantità interessanti di questi preziosi metalli. Le valli piemontesi delle Alpi occidentali, i depositi alluvionali sardi, le formazioni geologiche dell’Appennino tra Abruzzo e Calabria, persino i terreni vulcanici toscani: tutti potrebbero celare tesori inaspettati, attendendo solo le giuste tecnologie per essere valorizzati.
La visione europea, condivisa dall’Italia, delinea un orizzonte ambizioso: entro il 2030, il continente dovrà estrarre il 10% del proprio fabbisogno di materie prime critiche, riciclarne il 25% e lavorarne il 40%. I vertici europei assicurano: l’obiettivo è raggiungibile, così come appare plausibile l’autosufficienza nella fornitura di litio entro lo stesso periodo.
I progetti italiani selezionati dall’Unione Europea testimoniano questo cambio di paradigma. In Toscana, il recupero del palladio dai catalizzatori esausti; nel Lazio, l’idrometallurgia applicata ai rifiuti industriali; in Sardegna, un hub per il trattamento delle batterie a fine vita, in Veneto, il riciclo dei magneti permanenti per estrarne terre rare.
Parallelamente, il progetto ACROBAT, con la partecipazione di ENEA, mira a recuperare oltre il 90% delle batterie al litio ferro fosfato esauste. L’ambizione italiana è chiara: ridurre di un terzo la dipendenza dall’estero nel campo delle materie prime critiche entro i prossimi quindici anni. Un obiettivo che si intreccia con il dibattito sul ritorno al nucleare, che raccoglie consensi trasversali, sebbene permangano interrogativi su modalità, tempistiche e localizzazioni.
Così, mentre l’Europa riscopre le virtù dell’autarchia strategica, l’Italia torna a scavare, non più solo alla ricerca di reperti archeologici, ma di un futuro meno dipendente dall’esterno. La terra che per millenni ha nutrito civiltà con i suoi frutti potrebbe ora alimentarne la tecnologia con le sue rocce, in un ciclo di rinnovata valorizzazione del patrimonio geologico nazionale.